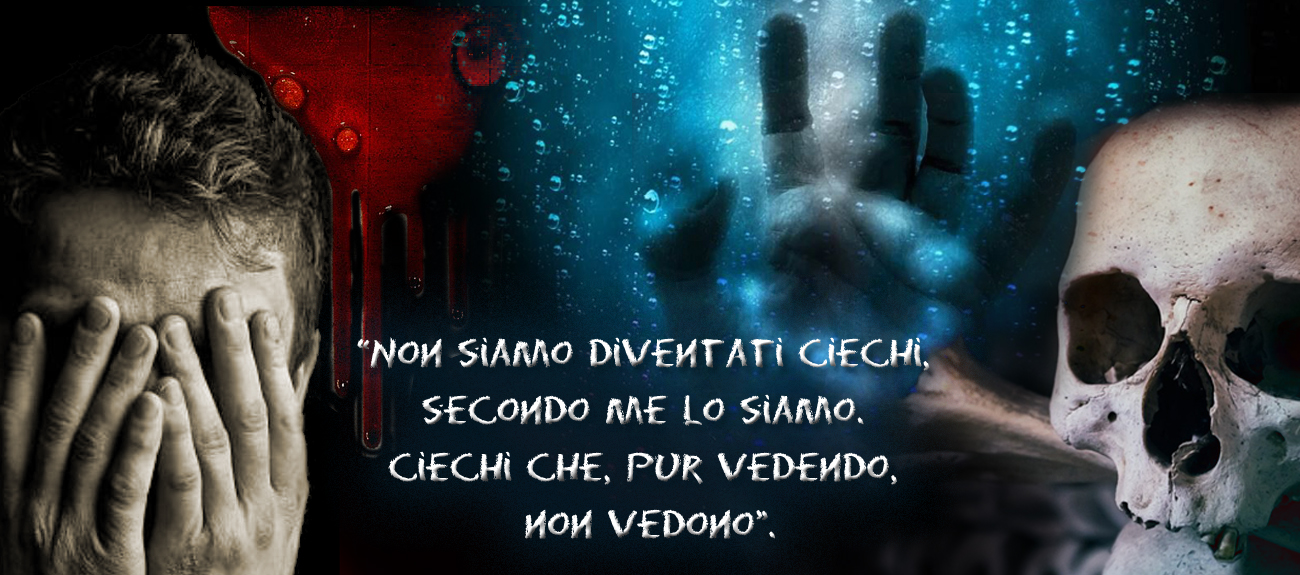Se la profezia viene dal romanzo, genere notoriamente immaginativo, allora come dobbiamo trattarla? Come un delirio dell’arte, una ipotesi della logica? Un’indicazione del sesto senso?
Questo è ciò che accade a Saramago con “Cecità”, capolavoro indiscusso, grottesco nella sua drammaticità, lineare nella prosa, contorto negli stati d’animo in grado di attivare in noi, alla lettura. Si tratta di un altro contesto, un’altra epidemia, eppure quegli isolamenti, quelle diffidenze e reazioni ci ricordano le nostre, forse meglio celate perché nel nascondimento letterario tutto è alla luce, eppure sono quelle, sì, ci riconosciamo nel medico vittima e carnefice involontario, nella moglie innamorata che ne condivide la sorte, nel minore che piange e si affida alle cure della sconosciuta con istinto materno, e in molti altri frammenti di umanità, personaggi dell’opera.
“È di questa pasta che siamo fatti, metà di indifferenza e metà di cattiveria.” Ammiccano verità, nella trama, intarsiate come perle e custodite gelosamente nel fondo di un mare che si agita e ci confonde: il contagio irresistibile, che non si può frenare. Ma lo sguardo dell’autore è fisso su un altro male, non quello del corpo, ma quello che corrompe l’animo umano e si espande con la paura: quali altri orrendi contagi invisibili siamo in grado di propagare?
“Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono.” E così a volte non si vede più pur vedendo, si perde quel limite che solo l’etica è in grado di porre, il confine tra il bene e il male. Essere ciechi, il sintomo dell’epidemia letteraria, è simbolico, se a un certo punto smettiamo di vederci e ce ne accorgiamo è una scossa violenta, forse l’inizio di una guarigione: vedere il male è la possibilità di arrestarlo. Una possibilità che l’umanità, somma di singolarità spietate, non coglie. Nemmeno il comune destino di morte ci ha unito, direbbe Nietzsche, cosa possiamo sperare? Possibile che anche noi ci stiamo svegliando, all’impatto con un’epidemia mortale? E dopo cosa faremo? Al bivio quale la strada che imboccheremo? Quella indicata da Saramago e dettata dalla nostra natura egoista o l’altra, che ci suggerisce di fare un passo indietro e salvare quella fiammella che ci rende umani?
Nel suo libro “Profezie”, Sylvia Browne racconta con occhio “cieco” e profetizzante del virus che nel 2020 al massimo ci avrebbe costretto a uscire di casa con guanti e mascherine. Lo fa nel 2004. Poi descrive scenari surreali, alcuni si sono verificati altri no, crisi dell’umanità, rivoluzioni alimentari e cicli di rigenerazioni a lungo termine ma ciò che colpisce è la coincidenza con ciò che stiamo vivendo adesso. Altra previsione del 2020 lo smart working che incede, non così definito, ma allo stesso modo, nelle sue previsioni, dilagante e definitivo dovunque, anche a scuola, ad eccezione delle elementari. “Profezie” non è un romanzo, ma la raccolta di visioni di una sensitiva a cui è riuscito il colpo, ma non del tutto. La differenza tra i due esempi letterari sta forse nell’idea di “attesa”, in cui ci tiene Browne, non Saramago. Nella relazione di quelle parole, situate in un altrove isolato, che è lo spazio del libro, e il nostro futuro, che è lo spazio di tutti. Solo con la Browne, leggendo tremiamo, e poi sorridiamo, perché ci aspettiamo davvero che quelle cose prima o poi accadano. Se “Profezie” fosse stato un romanzo non saremmo andati per il sottile, e avremmo forse trovato straordinaria la parziale coincidenza di eventi, come succede di fronte a “Cecità” di Saramago, che non aveva ambizione di inseguire il futuro, e lo incrocia, disgraziatamente. Inaspettatamente.

Mi chiamo Irene e sono il direttore di questo magazine on line, fondato con l’Associazione Culturale “Le Ciliegie”. Nel lontano 2003 mi sono laureata in Filosofia con 110 su 110 e lode, tesi in Bioetica sull’esistenzialismo francese, e proprio come Jean Paul Sartre, mio filosofo del cuore, ho idea che “terminerò la mia vita esattamente come l’ho iniziata: tra i libri”. Sono una giornalista culturale e una docente di Filosofia e Storia: il giornalismo è la mia scusa per scrivere, l’insegnamento la mia palestra. Ma la verità, dietro tutte queste maschere di carne, è che sono una scrittrice, e scorre inchiostro nelle mie vene.